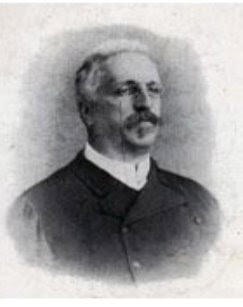L'organo della Chiesa di Santa Maria Assunta a Montanaro (To)
1) ORGANI STORICI ALESSANDRO MENTASTI 1884 OP. 70 - 1892
tromba, Ercole Ceretta
organo, Roberto Cognazzo
EDIZION LEONARDI LOCD020
2) ARTE ORGANARIA A CENTALLO: LA FAMIGLIA VITTINO
organo, Roberto Cognazzo
EDIZION LEONARDI LOCD026
3) ORGANO FRATELLI SERASSI 1821 OP. 385 - CHIESA DI S. MARTINO VESCOVO - AZEGLIO (TO)
clarinetto basso, Rocco Parisi
organo, Roberto Cognazzo
EDIZION LEONARDI LOCD029
4) ORGANO FRATELLI LINGIARDI 162 OP. 128 - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - COCCONATO (AT)
organo, Roberto Cognazzo
EDIZION LEONARDI LOCD039
5) ORGANO GIUSEPPE RAMASCO 1770 - CHIESA DI S. ANTONIO - BIELLA/CHIAVAZZA
organo, Walter Savant-Levet
EDIZION LEONARDI LOCD015
6) ORGANO GIOVANNI BRUNA 1793-95 - CHIESA DI S. SILVESTRO PAPA - CHIAVERANO (TO)
organo, Walter Savant-Levet
EDIZION LEONARDI LOCD033
7) ORGANO CARLO VEGEZZI-BOSSI 1891 - CHIESA DI S. FRANCESCO - TONENGO DI MAZZE' (TO)
organo,Walter Savant-Levet
EDIZION LEONARDI LOCD037
8) ORGANO FRATELLI SERASSI 1821 OP. 385 - CHIESA DI S. MARTINO VESCOVO - AZEGLIO (TO)
organo, Massimo Gabba
EDIZION LEONARDI LOCD025
9) ORGANO FRATELLI SERASSI 1833-34 OP. 486 - CHIESA DI S. EMILIANO - CIGLIANO (VC)
organo, Massimo Gabba
EDIZION LEONARDI LOCD028
10) ORGANO GIOVANNI BRUNA 1793-95 - CHIESA DI S. SILVESTRO PAPA - CHIAVERANO (TO) - «Musica d'organo nel Regno Sabaudo»
organo, Daniele Sajeva
EDIZION LEONARDI LOCD034
Prima di addentrarci nella vera e propria recensione dei 10 CD tratti dalla serie «Antichi Organi del Canavese», dobbiamo fare un po' di luce sulla storia di questa lodevole iniziativa editoriale - tutta italiana - chiariamo subito che il Canavese è un'area geografica posta nella zona settentrionale della provincia di Torino, a nord-est della città, ed il suo centro principale è Ivrea.
La collana discografica «Antichi Organi del Canavese» delle Edizioni Leonardi di Milano, nasce nel 1996 da un’idea di Adriano Giacometto (storico dell'arte organaria) e Roberto Ricco (tecnico del suono) in seguito alla proposta della Pro Loco di Montanaro (To) di realizzare la registrazione del loro monumentale organo appena restaurato (questo disco, ora esaurito, aveva come protagonisti l'eclettico musicista monferrino Roberto Cognazzo ed il magnifico strumento dei fratelli Bruna riedificato nel 1872 da Giacomo Vegezzi-Bossi.
La filosofia della collana (giunta ora a ben 26 volumi realizzati con l'ausilio di 27 diversi organi storici) si può riassumere così: studio, diffusione e valorizzazione dell’importante patrimonio organario canavesano, primo a livello regionale, tra i maggiori a livello nazionale.
Inoltre, dal 1999 «A.O.C.» ha attivato un proprio sito (http://www.antichiorganidelcanavese.it/) sul quale è possibile effettuare ascolti, nonché consultare articoli, testi e fotografie riguardanti gli organi storici del Piemonte. Autorevoli consensi lo hanno legittimato come il più importante sito territoriale italiano sugli organi storici, e noi gliene diamo sicuramente atto.
Venendo alla musica, cominciamo col parlare dei 4 CD realizzati da Roberto Cognazzo - “storica” colonna portante della serie - assolutamente imperdibili non solo per chi predilige l'Ottocento organistico italiano, ma anche per chi ama il melodramma ed esige dall'interprete musicalità, personalità e partecipazione emotiva.
Scorgendo i nomi di alcuni compositori eseguiti (Arditi, Marenco, von Suppé, Adam, Gomes, Offenbach, Délibes...) viene da chiedersi se questi siano stati anche autori di pagine espressamente organistiche. Ebbene, la risposta è no! E' l'interprete che assume il ruolo di maestro concertatore sfruttando al massimo le potenzialità degli organi-banda, ricchi di molti registri da concerto ed effetti tipici dell'organico strumentale impiegato nella musica operistica ottocentesca. Strumenti in cui accanto al classico Ripieno trovano posto numerosissimi strumenti da concerto, nonché svariati effetti rumoristici e coloristici, come la Banda turca, il Rollante, i Timpani, i Campanelli e le Campane (gli strumenti realizzati non solo dai celeberrimi organari bergamaschi Serassi, ma anche dai pavesi Lingiardi, dai novaresi Mentasti, dai cuneesi Vittino, etc.)
Pianista, organista, musicologo e compositore, Roberto Cognazzo è uno dei pionieri della riscoperta dell'organo italiano ottocentesco, avvenuta nella seconda metà del Novecento grazie a figure quali Luigi Ferdinando Tagliavini prima, Giancarlo Parodi ed Arturo Sacchetti poi. Nel corso del tempo si è adoperato per la diffusione della letteratura organistica, ma soprattutto si è dedicato ad orchestrare all'organo numerosi lavori operistici e sinfonici (molto in voga all'epoca ed oggi quasi dimenticati), come si usava fare nell'Ottocento. Si spiega allora la presenza di alcuni titoli inusuali come Il Gurany di Antonio Carlos Gomes, Marta di Friedrich von Flotow, Romilda e Costanza di Giacomo Meyerbeer o il balletto Excelsior di Romualdo Marenco. Musiche di raro ascolto nella versione originale, figuriamoci poi in trasposizioni organistiche!
Nella registrazione effettuata sul Lingiardi di Cocconato, Cognazzo esalta in maniera sublime la ricca tavolozza timbrica dello strumento sfoderando un programma che parte da brani danzanti come l'Ouverture da Leichte Kavallerie di Franz von Suppé, passando per l'incalzante Prélude da Carmen di Bizet (con tanto di colpo di Gran Cassa ad hoc), sino ad arrivare a sontuosi brani sinfonici come le Suites dal Lago dei cigni di Ciaikovskij e dal Peer Gynt di Grieg. Ma, l'autentico gioiello del disco è rappresentato dal Largo della Nona Sinfonia di Dvoràk in cui la cantabilità del Corno Inglese, la morbidezza dei Corni dolci e della Flutta, il lirismo della Voce Umana rifulgono nella sua toccante interpretazione. Cognazzo è un artista che non si “risparmia” mai, suonando sempre con grande tensione, come se si trattasse di un concerto dal vivo.
Nella registrazione realizzata sul Serassi di Azeglio insieme all'organo possiamo ascoltare anche il clarinetto basso di Rocco Parisi (nel CD dedicato ai Mentasti c'era, invece, l'eloquente tromba solista di Ercole Ceretta) che per l'occasione si trasforma nella voce calda di un raffinato cantante. Buoni fiati, ottimo legato, agilità e chiarezza da vendere il tutto unito ad un forte senso del discorso musicale; tutte doti che non fanno rimpiangere le voci del Cardinale Brogni, Figaro, Tonio, Violetta, Amina, etc. Ancora, la Sinfonia da Romilda e Costanza - la prima opera italiana di Meyerbeer - viene incisa per la prima volta in questo Cd, pensate non da un'orchestra, bensì appropriata all'organo!
Proseguiamo parlando dei 3 CD del torinese Walter Savant-Levet, acuto e versatile interprete, molto “pulito” e brillante, sempre musicale. Nei due dischi antologici oltre a mostrare una coerenza stilistica davvero encomiabile - spaziando non solamente da epoca a epoca, ma anche da scuola a scuola - pone in risalto con grande maestria le peculiarità timbriche dei due preziosi organi settecenteschi (Giuseppe Ramasco e Giovanni Bruna). Peccato, però, per quella Gran Sinfonia dal Tancredi di Rossini, che mette a dura prova i “polmoni” del Bruna di Chiaverano!
Eccezionale il CD dedicato ai francesi Louis Lefébure-Wely e César Franck interpretati da Savant-Levet sul magnifico organo realizzato da Carlo Vegezzi-Bossi (1891) per la chiesa di S. Francesco a Tonengo di Mazzè (To). Come dicevamo, l'organo a canne in Italia veniva inteso in pieno Ottocento «a guisa di banda», mentre in Francia veniva recepito come un'orchestra, non ancora nel senso sinfonico del termine, bensì in grado di riprodurre l'organico tipico dei Ballet della Grand Opera. Ed è proprio Lefébure-Wely ad incarnare la figura di organista “alla moda” con i suoi brani ballabili e salottieri, piuttosto che caratteristici e descrittivi, alcuni dei quali Savant-Levet propone con grande eleganza. Quelli più famosi rimangono sicuramente Scène pastorale (brano idilliaco con tanto di flauti, zampogne, temporali...) e Fantasie sur La Flûte Enchantée de Mozart (fantasiosa parafrasi dei motivi più famosi tratti dall'opera - non dimentichiamo che Lefébure-Wely riscosse anche la stima di Liszt). L'anima romantica del Vegezzi-Bossi emerge, però, nei due capolavori di Franck, Pièce héroïque e Choral 3 en la mineur. Due poemi sinfonici per organo - il secondo dei quali è accostabile solo ai più mistici capolavori di J. S. Bach - disegnati dall'organista torinese con uso del colore e senso della forma esemplari.
I 2 CD di Massimo Gabba comprendono: il primo, un'antologia di brani che vanno dal Barocco italiano e tedesco passando per il Classicismo italiano e viennese sino ad arrivare al Romanticismo Italiano. La cifra stilistica che contraddistingue la lettura dell'organista alessandrino è il rigore del tempo unito alla quadratura del discorso musicale. Di grande pregio musicologico, poi, l'inserimento di due brani di raro ascolto di Johann Simon Mayr (Preludio e Fuga in sol) e soprattutto due Versetti di Felice Frasi (1805-1879), compositore piacentino tra i più richiesti collaudatori d'organi d'Italia. Il secondo disco consegna, invece, una personale versione approntata da Gabba, dei Quadri di un'esposizione di Mussorgsky, ricavata compendiando l'originale versione per pianoforte e quella orchestrale di Ravel. Si tratta della prima versione registrata su un organo storico italiano - nella fattispecie il Serassi di Cigliano - del capolavoro mussorgskyano. Infatti, si conoscono diverse versioni organistiche approntate nel Novecento del Vecchio Castello, ma dell'intera opera si ricordano soprattutto quelle di Wills e di Guillou, entrambi concepite per grande organo sinfonico.
Il disco di Daniele Sajeva chiude la panoramica sul patrimonio organario del Canavese offrendo un inedito programma dal titolo «Musica d'organo nel Regno Sabaudo» in cui risuonano per la prima volta musiche di compositori locali, quali Ignazio Pacotto (1763-1834), Carlo Gervasoni (1762-1819), Carlo Prola, Luigi Felice Rossi (1805-1863), nonché di grandi che ebbero contatti col Piemonte (ad esempio il cugino di Couperin «le Grand» ed il giovane Mozart). Purtroppo, nonostante certe tonalità siano state trasposte a causa del temperamento mesotonico dell'organo Bruna, molti brani appaiono lo stesso stridenti a causa di alcuni intervalli al limite dell'impraticabilità. Comunque sia, lode al merito a Sajeva per aver effettuato un'accurata ricerca d'archivio ed aver disseppellito rarità musicali legate all'organo piemontese.
Mi pare molto importante, infine, segnalare che in tutte le registrazioni vi è una presa del suono del tutto naturale, così che il messaggio sonoro - anche se a volte un poco “grezzo” - non subisca alcuna alterazione (equalizzazione, compressione/espansione, eco artificiali) né in sede di registrazione né durante l’editing digitale.